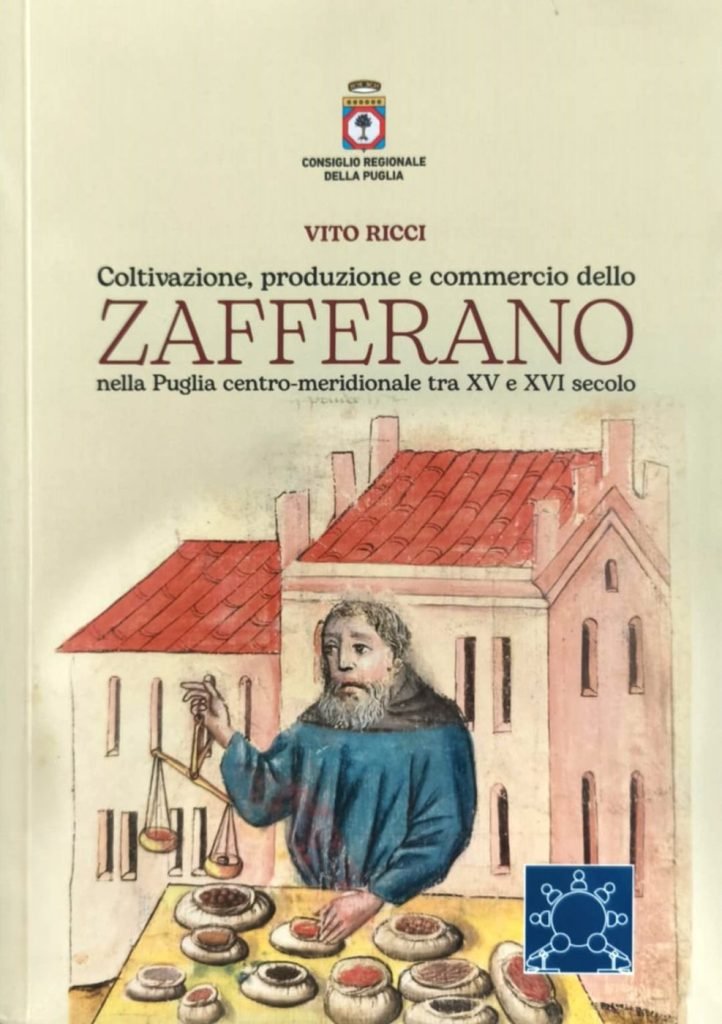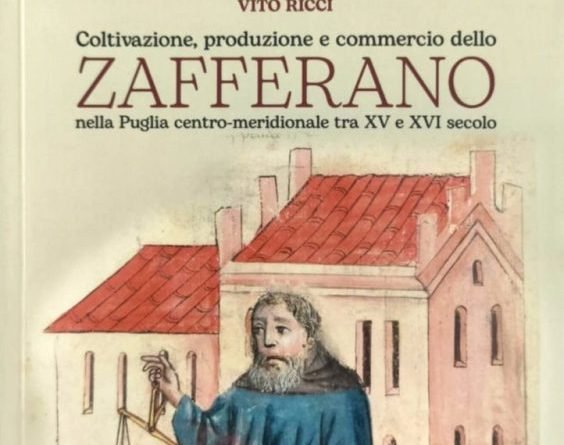Coltivazione, produzione e commercio dello zafferano nella Puglia centro-meridionale tra XV e XVI secolo
Lo zafferano nel corso del Medioevo e del Rinascimento era una delle spezie più ricercate e utilizzate per i suoi molteplici utilizzi (cucina, tintura, cosmesi, farmacia). La sua preziosità ne faceva un bene di lusso con un importante commercio a livello internazionale. L’Italia era il principale produttore in Europa, assieme alla Spagna e, in misura minore, alla Francia; lo zafferano italiano era tra le qualità più pregiate. Nel Regno di Sicilia vi erano due zone di produzione: gli Abruzzi e la Puglia, ma mentre il primo ambito territoriale ha ricevuto notevole attenzione da parte degli studiosi, il secondo non ha mai avuto una trattazione organica. A supplire a tale mancanza vi è il recente volume Coltivazione, produzione e commercio dello zafferano nella Puglia centro-meridionale tra XV e XVI secolo di Vito Ricci, pubblicato nella collana editoriale “Leggi la Puglia” del Consiglio regionale della Puglia. Il lavoro si sofferma sul periodo di maggiore importanza per la crococoltura nella nostra regione nella parte centro-meridionale (Terra di Bari, Terra d’Otranto) compreso tra XV e XVI secolo. Prima di addentrarsi nella trattazione del caso pugliese, l’Autore propone una variegata riflessione sullo zafferano in epoca medievale, sui luoghi di produzione e i mercati in Europa e in Italia, sul ruolo della spezia all’interno delle pratiche della marcatura, con particolare riguardo a quelle in lingua tedesca (come lo Handelsbuch di Lorenz Meder del 1558) poco conosciute in ambito italiano. Le prime notizie dello zafferano pugliesi si hanno agli inizi del Quattrocento, quando era già presente sul mercato fiorentino, è molto verosimile che la coltura abbia avuto diffusione dopo la Peste Nera, quando presero il sopravvento in Europa le colture specializzate ad alto valore aggiunte. Venivano ad acquistare zafferano nelle province pugliesi mercanti toscani, veneziani, ragusei e poi, da fine Quattrocento, si affermarono quelli tedeschi (Baumgartner, Welser, Imhoff) che divennero, nei fatti, dei veri e propri monopolisti. L’opera si distingue per la capacità dell’Autore di inserire le dinamiche locali in contesti più ampi.
In Terra di Bari, secondo le notizie riportate dai Baumgartner, la coltivazione dello zafferano era praticata nei comuni di Bari, Modugno, Palo del Colle, Bitritto Acquaviva, Casamassima, Cassano e Sannicandro, la produzione annua variava dalle 4.000 alle 5.000 libbre (circa 1.520-1.900 kg). L’Autore propone due casi di studio sui quali si sofferma: Bitonto per il secolo XV e Bisceglie per il XVI. Maggiore sviluppo ebbe la coltivazione dello zafferano in Terra d’Otranto, dove i centri di produzione erano diversi (Nardò, Gallipoli e Massafra erano quelli più rinomati tra i mercanti tedeschi) e la produzione più abbondante (tra le 8.000 e le 9.000 libbre, circa 3.040-3.420 kg) e di qualità migliore rispetto a quella di Terra di Bari. Altri argomenti affrontati nel volume sono quello delle fiere durante le quali lo zafferano era venduto nel periodo autunnale, dando vita ad un vero circuito che andava da Lucera sino ad Otranto, e quello degli aspetti fiscali legati al commercio della spezia: “Essendo un bene di lusso, destinato ai mercati internazionali, con un prezzo elevato e con la possibilità di profitto notevoli, lo zafferano era assoggettato ad un particolare regime fiscale tanto in ambito regnicolo, quando in quello locale” scrive l’Autore.
La ricerca si caratterizza per il rigoroso impianto metodologico e per l’ampio uso di fonti archivistiche inedite. L’Autore ha saputo valorizzare documentazione proveniente dall’Archivio di Stato di Napoli, dalla Basilica di San Nicola di Bari, dall’Archivio Diocesano di Bisceglie e dall’Archivio di Stato di Bari, restituendo un quadro articolato delle dinamiche produttive e commerciali locali, dimostrando l’importanza della coltivazione dello zafferano assunta nell’economia delle due provincie pugliesi, “periferie al centro dei circuiti commerciali internazionali, coltura spesso marginalizzata e penalizzata dalla ricerca storica, a vantaggio dell’olivicoltura”.
Il volume di Ricci si configura come un contributo solido e ben documentato sulla storia economica del Mezzogiorno e colma una lacuna significativa nella storiografia meridionale, affrontando per la prima volta in maniera organica la coltivazione e il commercio dello zafferano in Puglia tra Tardo Medioevo e Rinascimento. Non è solo una ricerca di nicchia per specialisti: chiunque sia interessato alla storia economica medievale, al commercio internazionale o alla storia della Puglia troverà in questo volume una lettura stimolante e ricca di scoperte.